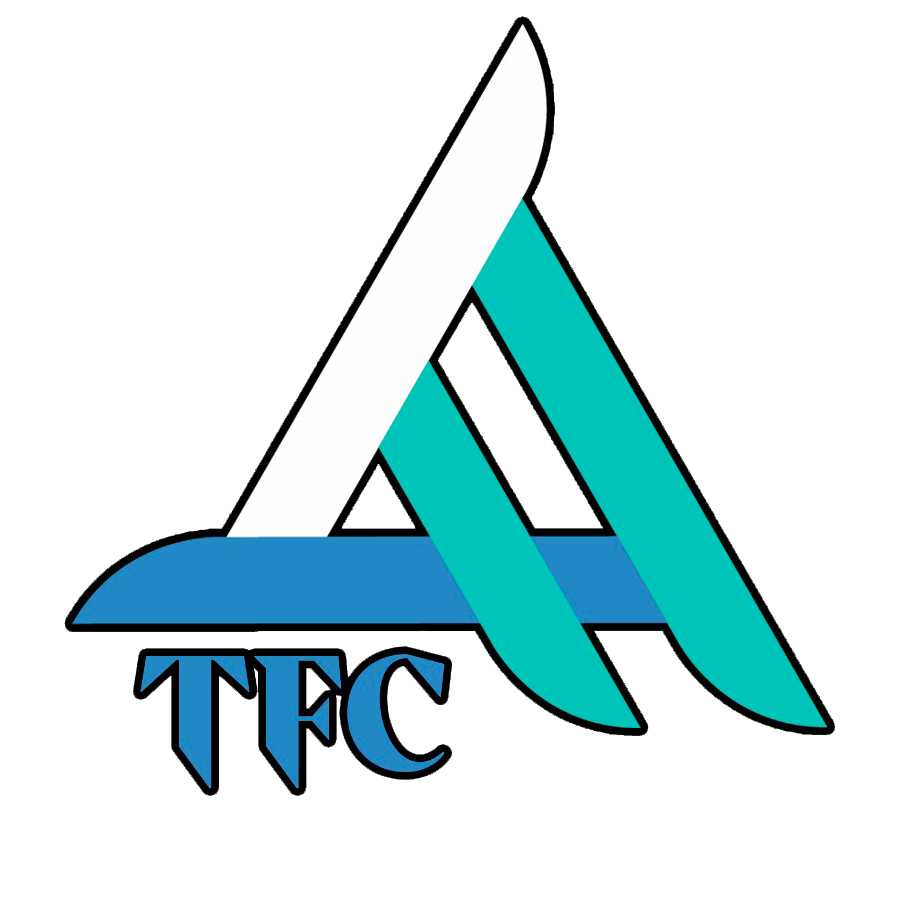R&S 2015-2019
14 Sep 2025
Sintesi
Dalle ultime evoluzioni interpretative emerge un possibile spostamento dell’asse: meno centralità ai cinque criteri del Manuale di Frascati, più ancoraggio al D.L. 145/2013 e al D.M. 27/05/2015. In questo quadro, la distinzione tra attività di R&S e “modifiche ordinarie” diventa il discrimine decisivo; nei casi in cui i progetti ricadano in quest’ultima categoria, il credito tende ad essere qualificato come “inesistente” (e non solo “non spettante”), con sanzioni più pesanti e termini di recupero più estesi. Sul piano temporale, la pressione è accresciuta dall’art. 19 del D.L. 25/2025 (convertito in L. 69/2025), che ha prorogato di due anni i termini di decadenza per gli atti relativi a crediti utilizzati nel 2016 e nel 2017, spingendo l’orizzonte dei controlli fino al 31/12/2026 – 31/12/2027 e rendendo più incisiva, anche a distanza di anni, la distinzione tra R&S e ‘routine’.
Il baricentro normativo: cosa NON è R&S
Nel perimetro 2015–2019 il baricentro interpretativo si è spostato dalla griglia concettuale del Manuale di Frascati alla sostanza legale della misura. Il D.L. 145/2013 e il D.M. 27/05/2015 individuano infatti, per via negativa, ciò che non è R&S: “non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche […] anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti”. Ne consegue che migliorare non basta se il miglioramento è di natura ordinaria: in tali ipotesi difetta il requisito oggettivo dell’agevolazione e la contestazione scivola sul terreno dell’inesistenza del credito (non della mera non spettanza). In questo quadro, venuta meno la “retro-centralità” di Frascati come filtro decisivo, una parte delle posizioni è stata effettivamente ricondotta alla non spettanza; tuttavia sopravvive una via diretta all’inesistenza quando il progetto è riducibile a semplice ‘modifica ordinaria’ (anche quando rappresenta un miglioramento) rispetto al perimetro legale 2015–2019. Il fulcro operativo diventerebbe, dunque, la tassativa esclusione della ‘routine’, come indicato nella norma: non l’adesione a criteri metodologici astratti, ma la verifica, in concreto, che l’intervento non sia mera ‘manutenzione evolutiva’ priva del presupposto sostanziale richiesto dalla disciplina.
La proroga dei termini e la sua logica sistemica
La proroga dei termini trova base nell’art. 19 del D.L. 14 marzo 2025, n. 25 (conv. L. 9 maggio 2025, n. 69). L’art. 19, intervenendo sul comma 12 dell’art. 5 del D.L. 146/2021, dispone in deroga allo Statuto del contribuente (L. 212/2000, art. 3, c. 3) una proroga di due anni del termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero (o altri provvedimenti impositivi) con riferimento ai crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017. Il testo recita, in sintesi: «il termine di decadenza … è prorogato di due anni … con riferimento ai crediti d’imposta … utilizzati negli anni 2016 e 2017». Tale estensione allunga l’orizzonte dei controlli su parte del quinquennio 2015–2019. Tale proroga sembrerebbe coerente con questo scenario: se il fronte residuo davvero critico è l’inesistenza, servono finestre temporali più ampie per presidiare i casi in cui la routine (pur migliorativa) abbia generato crediti privi del presupposto. Ne discende, in pratica, una riattivazione a lungo raggio sul quinquennio 2015-2019, con scadenze che, nei casi peggiori, scivolano fino al 31/12/2028 (la prescrizione più vicina è fissata al 31/12/2026, poi al 31/12/2027 ed infine al 31/12/2028).
Criticità operative: la sottile linea tra “miglioramento tecnico” e “routine”
Tra il 2015 e il 2019 il ‘confine’ tra “miglioramento tecnico, obiettivo principale di progetto” e “modifica considerata ordinaria anche quando rappresenta un miglioramento” è spesso sfumato. La norma dice che le “modifiche ordinarie o periodiche, anche se migliorative” non sono R&S, ma non spiega con chiarezza dove passi il limite. Così la valutazione finisce spesso per dipendere da come la si interpreta, più che da regole precise. Col tempo, questo effetto si amplifica: guardando a posteriori, ciò che allora era nuovo oggi può sembrare scontato e potrebbe essere letto come semplice ‘routine’.
Il nodo principale: differenze tra novità per il settore, novità per l’impresa e assenza di novità
Novità per il settore
Nuove idee ed originali soluzioni di problematiche/criticità/carenze dello stato dell’arte del settore spostano avanti la frontiera tecnologica. Non si trovano già “pronte sullo scaffale” e richiedono tentativi, prove, rischi. In questo caso, il progetto risponderebbe ai requisiti del Manuale di Frascati e il credito verrebbe considerato, da un mero punto di vista tecnico, “esistente”.
Novità per l’impresa
La soluzione è nuova per quell’azienda, ma nel mercato era già conosciuta o accessibile, quindi, anche se il prodotto finale migliora, l’intervento può essere giudicato come evoluzione aziendale. In questo caso (stante le ultime indicazioni normative e sentenze che limitano notevolmente il ruolo del Manuale di Frascati) il progetto non risponderebbe ai requisiti del Manuale di Frascati, che però non è indicato nella norma primaria e secondaria (DL 145/2013 e DM 27/05/2015), e quindi il credito verrebbe considerato esistente ma “non spettante”.
Assenza di Novità
(modifiche considerate ‘ordinarie’, anche quando rappresentano miglioramenti): caso di progetto che, oltre a non essere nuovo per il mercato, non lo è nemmeno per l’Impresa in quanto le soluzioni tecniche adottate si riferirebbero solo a modifiche ordinarie, anche quando rappresentano miglioramenti, apportate a prodotti/processi/servizi esistenti. In questo caso, il credito verrebbe considerato “inesistente”, perché vi è mancanza, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi fissati dalla norma (DL 145/2013 e DM 27/05/2015). E qui sorge un problema: distinguere un “miglioramento tecnico, obiettivo principale di progetto” (credito ‘esistente’ se il miglioramento è considerato nuovo per tutto il settore, oppure credito ‘non spettante’ se il miglioramento è considerato nuovo solo per l’impresa) da una “modifica considerata ordinaria, anche se apporta miglioramenti” (credito considerato ‘inesistente’), in molti casi sarebbe abbastanza complesso a causa della notevole somiglianza ‘tecnica’ tra i due concetti e dell’assenza di specifiche regole chiarificatrici. In sostanza, la criticità consiste nel riuscire a dimostrare, in modo chiaro, quando un miglioramento tecnico progettuale deve essere considerato ‘significativo’ (novità quantomeno per l’impresa) e quando, invece, deve essere considerato ‘poco significativo’ (assenza di novità).
Questa distinzione è significativa perché l’esito visibile (un prodotto o un processo “migliorato”) può nascere sia da esperimenti veri e propri, sia da semplici ottimizzazioni. Senza criteri chiari, chi controlla tende a valutare ciò che si vede più che come ci si è arrivati. Inoltre, alcuni fattori confondono ulteriormente il quadro: in settori che corrono veloci, la “novità” cambia significato in fretta; ad esempio, nel software o nel design di processo le tracce sono meno “fisiche” e risultano meno intuitive; progetti che integrano componenti già note vengono spesso percepiti come attività ‘ordinarie’ (anche se rappresentano miglioramenti); e con il passare degli anni documenti e ricordi si assottigliano. Il risultato è una maggiore variabilità nelle decisioni su casi di ‘confine’ tra novità per il settore, novità per l’impresa e modifiche considerate ‘ordinarie’ anche se rappresentano miglioramenti (assenza di novità).
Implicazioni strategiche
- Rimappatura del portafoglio progetti (2015–2019): priorità ai casi con deliverable incrementali; verifica del nesso tra esigenze di ‘mercato’ e quelle di ‘impresa’, incertezza tecnica iniziale, sperimentazione ed avanzamento non routinario/non ordinario.
- Narrativa tecnica disciplinata: formalizzazione dell’obiettivo principale e della originalità delle soluzioni progettuali.
- Approfondimenti: con asset brevettuali (brevetti indipendenti, dipendenti, derivati di combinazione/perfezionamento/traslazione, modelli di utilità) e letteratura/stato dell’arte per misurare il delta tecnico e superare l’argomento “mera routine”.
- Team multidisciplinare: presidio con competenze progettuali, sperimentali, brevettuali, accademiche, memorie tecniche per contenziosi e risposte a contestazioni amministrative o tributarie, profonda conoscenza di specifici documenti tecnici (Manuale di Frascati, Manuale di Oslo, Codice Proprietà Industriale, Linee Guida EPO). Ad esempio, per distinguere adeguatamente i “miglioramenti tecnici, obiettivi principali di progetto” dalle “modifiche ordinarie, anche se rappresentano miglioramenti” (no R&S, quindi credito “inesistente”), sarebbero necessari, secondo uno specifico format ‘multidisciplinare’, almeno 12 approfondimenti tecnici.
L’importanza di un Team multidisciplinare
Il possibile mutato baricentro verso la ‘distinzione’ tra novità per l’impresa e modifiche considerate ordinarie anche se rappresentano miglioramenti, nonché l’estensione dei termini di recupero, rendono centrale una struttura di presidio multidisciplinare. Non si tratta di un supporto accessorio ma di meccanismo di governo che consente di allineare evidenze tecniche, lettura giuridica e tracciabilità economico-contabile lungo l’intero ciclo di vita dei progetti svolti negli esercizi fiscali che vanno dal 2015 al 2019.
Composizione essenziale di Team multidisciplinare
- Tecnico-scientifico
Formalizza e verifica le ipotesi di novità ed incertezza, piano sperimentale, test e iterazioni. Analizza le soluzioni progettuali, mediante specifico format di approfondimento multidisciplinare recante almeno 12 quesiti tecnici, al fine di escludere, il più possibile, il concetto di ‘modifiche considerate ordinarie anche quando rappresentano miglioramenti’.
- IP/Brevetti
Ausili per verifiche stato dell’arte ed anteriorità; qualifica il delta tecnico e profili di tutelabilità (anche modelli di utilità), raccordando linguaggio tecnico e standard brevettuali.
- Legale-tributario
Inquadra i fatti nella norma vigente per le attività svolte negli anni dal 2015 al 2019 (c.d. esclusione della routine), gestisce motivazioni e contraddittorio, garantisce coerenza formale dei provvedimenti e dei riferimenti.
- Amministrazione/controllo di gestione
Assicura la pertinenza e congruità dei costi, la riconciliazione tra WBS tecniche e contabilità, e la tracciabilità per annualità.
- PMO/Documentazione
Orchestra tempi, milestone probatorie e standard di archiviazione (nomenclature, timestamp, versioni), assicurando uniformità della rendicontazione.
Il team multidisciplinare è l’asse portante della coerenza probatoria: salda fatti tecnici, forma giuridica e numeri, minimizza le asimmetrie informative e riduce il rischio di riqualificazione in “inesistenza” nei controlli che, per effetto delle proroghe, possono insistere su annualità ormai lontane.
Conclusioni
Il punto di frizione non è più (solo) la coerenza ai criteri di Frascati, ma l’aderenza sostanziale alla definizione legale di R&S ai sensi del D.L. 145/2013 (L.190/2014) e del D.M. 27/05/2015, dove la ‘routine evolutiva’ è esclusa per de finizione.
In questa prospettiva, la proroga dei termini sembrerebbe essere funzionale a presidiare i casi di inesistenza legati alle modifiche considerate ordinarie anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Ne discende che la qualità della prova tecnica – non la forma – diventa l’argine reale contro la riqualificazione: dossier progettuali, sperimentazione tracciata, approfondimenti specifici e competenze integrate sono oggi il perimetro minimo di tutela.
Ing. Sauro Bianchelli